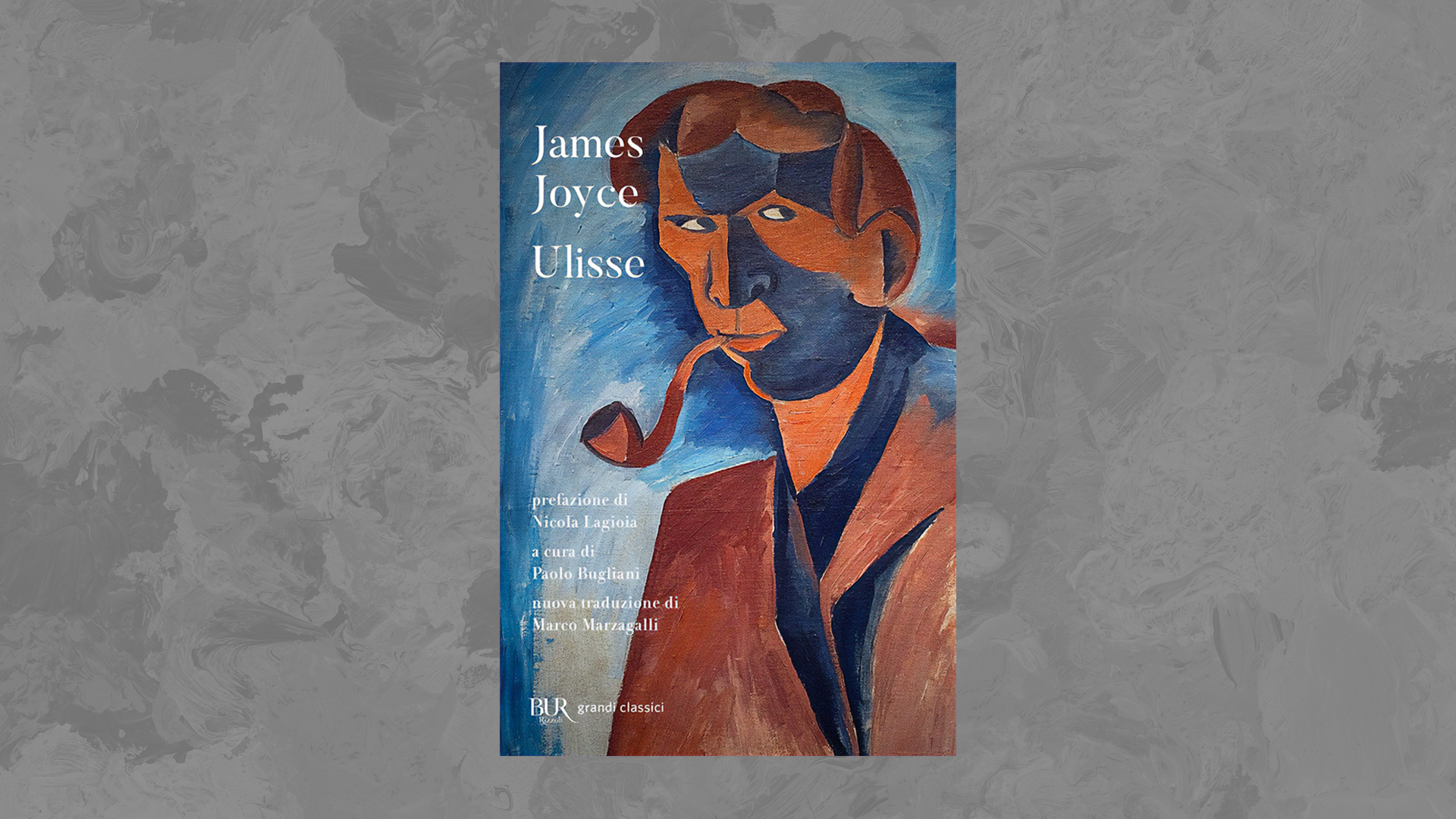Pathurnia
Well-known member
"La sposa giovane" di Baricco, un romanzo più "cool" che bello
Recensione colta al volo da https://www.wired.it/play/libri/2015/04/13/sposa-giovane-baricco-romanzo/Il ragazzo Baricco di suo sarebbe anche molto bravo, peccato che si applichi. Cioè che usi un di più di calcolo e costruzione, che sciupi una quasi spudorata facilità affabulatoria infarcendo i suoi romanzi di spunti, cataloghi, elenchi, doppifondi ed escrescenze varie che alla fine si rivelano vicoli chiusi e danno una sensazione finale, posato il libro, di entropia, di mancanza di centro narrativo. Di inconsistenza, sarei tentato di dire, come un bello spettacolo di fuochi d'artificio del quale resta solo il fumo.
Qui i protagonisti non hanno nome: sono il Padre, la Madre, il Figlio, la Figlia, lo Zio. E la Sposa giovane. Il luogo in cui vivono è del pari indeterminato, come lo è l'epoca storica: tra fine '800 e inizio '900, si deduce dal resoconto di due prodezze seduttive della Madre giovane. Il Figlio, che ha vent'anni, e la Sposa giovane, che ne ha diciotto, devono sposarsi, sono già fidanzati da tre anni ma lei è stata in Argentina al seguito del padre, lui è in Inghilterra a sorvegliare le fortune tessili dell'azienda di famiglia. Tornerà, dovrebbe tornare, lo aspettano come si attende Godot.
Se non hanno nome i protagonisti, lo hanno comprimari e comparse, a partire dal sapienziale maggiordomo Modesto che sale le scale come Cortazar insegnava si debbano salire le scale (la Famiglia ricorda in qualche modo i Cronopios e i Famas dell'argentino, con la crudeltà smussata in eccentricità più o meno blanda, più o meno innocua).
Nella Famiglia si temono la notte (tutti i membri sono morti al buio), i libri (c'è già tutto nella vita), le tristezze e tutto ciò che sfugga a un cerimoniale minuzioso quanto insignificante che “tiene in ordine il mondo”. Come le colazioni in pigiama che durano fino al pomeriggio, con o senza ospiti. Come il male necessario delle vacanze in montagna che vengono apparecchiate con settimane di anticipo smontando la casa. Come le rare visite del padre in città (al Bordello, luogo fondativo e scaturigine affabulatoria degna di Sheherazade).
In questa atmosfera da Alice senza meraviglie, la Sposa giovane è iniziata alla vita e all'arte della seduzione. Perché scrivi di sesso? chiede una donna che un tempo ha amato l'autore del libro. Perché è difficile, risponde l'autore del libro. È una risposta rivelatrice: Baricco, appunto, si applica.
C'è anche questo nella Sposa giovane: una voce narrante in perpetuo smottamento dalla terza alla prima persona (dell'autore, ma anche dei personaggi che spesso dicono al narratore onnisciente fatti più in là che continuo io) e dalla prima alla terza: le discese ardite e le risalite. Niente di sgradevole, anzi tutto abile e oliato: ma non è un po' virtuosistico? chiede un lettore all'autore (dentro il romanzo, non fuori). Forse, ma è così che si scrive, ribatte l'autore. Che si lancia in una digressione e previene l'obiezione del lettore: sto facendo una digressione ma me lo posso permettere, sono bravo e so quando posso arenare la barca sulla spiaggia, conosco il gioco delle maree.
Le conosce, non c'è dubbio. E ha una tale ansia di controllo totale della sua opera tutt'altro che aperta (il meccanismo, come accade nelle macchine celibi, è perfetto), da immaginarsi e “scegliersi” persino i lettori. In più, sa scrivere molto meglio dell'autrice delle 50 sfumature di tutti i colori a piacere. Così c'è sesso, lesbico e masturbatorio come in una fotografia alla Richard Avedon, molto patinato e per niente eccitante (ma la letteratura erotica di rado è anche erogena), molto spicciativo nell'unica copula (“lo presi dentro di me”, può bastare).
Ci sono i segreti dei personaggi: ognuno ha il suo, come una matrioska. E le invenzioni-digressioni. Che ogni tanto precipitano dal trovarobato surrealista alla battuta da oratorio: nei preparativi per la villeggiatura, oltre a coprire i mobili e riporre vestiti e stoviglie, si mettono via anche suoni e colori che verranno recuperati in seguito: e così l'avvocato Squinzi ritroverà in un cassetto un rutto che aveva emesso l'anno prima, buona questa! Oppure la Madre torna in casa a recuperare qualcosa e mormora tra sé “ma che vadano tutti a cagare” (“o forse a cantare”, aggiunge il narratore: è la stessa semantica dell'eufemismo che trasforma cristo in cribbio).
Ci sono le frasi tornite, quelle forbite e quelle superficialmente profonde o profondamente superficiali, buone come cartigli per i post-baci perugina senz'altro artigianali e senz'altro cool che prima o poi si venderanno da eataly.
In tanta munificenza, c'è una costruzione del sublime in odore di kitsch: i personaggi senza nome suonano più profondi, possiedono un'aura maggiore di quelli con un nome e un luogo, così come un manichino senza volto rende “metafisica” una piazza di De Chirico. Volete mettere se questa stramba Famiglia di industriali tessili si chiamasse, mettiamo, Loro Piana, e il luogo Biella? È lo stesso procedimento con cui negli spot si fa correre una fuoriserie tra ghiacciai, foreste e meravigliose corniches e non sulla Tiburtina, per cui nelle canzoni si scrive “uscir nella brughiera la mattina dove non si vede un passo” (nel prato? ma andiamo, che banalità), si fanno volare gli aironi e non i passeri; per cui i cantautori intonano il sublime, si fa per dire, “Hilde nel buio suonava la cetra” o “Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole” (Giaime Pintor, figlio di Luigi e critico musicale arguto e feroce, postillava: non è nobel, è solo rimmel).
Lo stile di Baricco (che ha un suo tono inconfondibile, un suo fraseggio riconoscibile), pure ammirevole, non riesce a sedurmi, è senz'altro un mio difetto. Trovo che il suo postmodern abbia un gusto di vecchio: di cascami surrealisti, di realismo magico, di prevertismi e sudamericanismi; che il suo virtuosismo ricordi più Lelouch che Salinger; che il suo immaginario ottonovecentesco sappia di rebus e di vecchia settimana enigmistica. Ciò detto, spesso si impiegano un paio d'ore a leggere di molto peggio.
(by Roberto Casalini)